Il dono d’amore: la fedeltà alla base della sofferenza
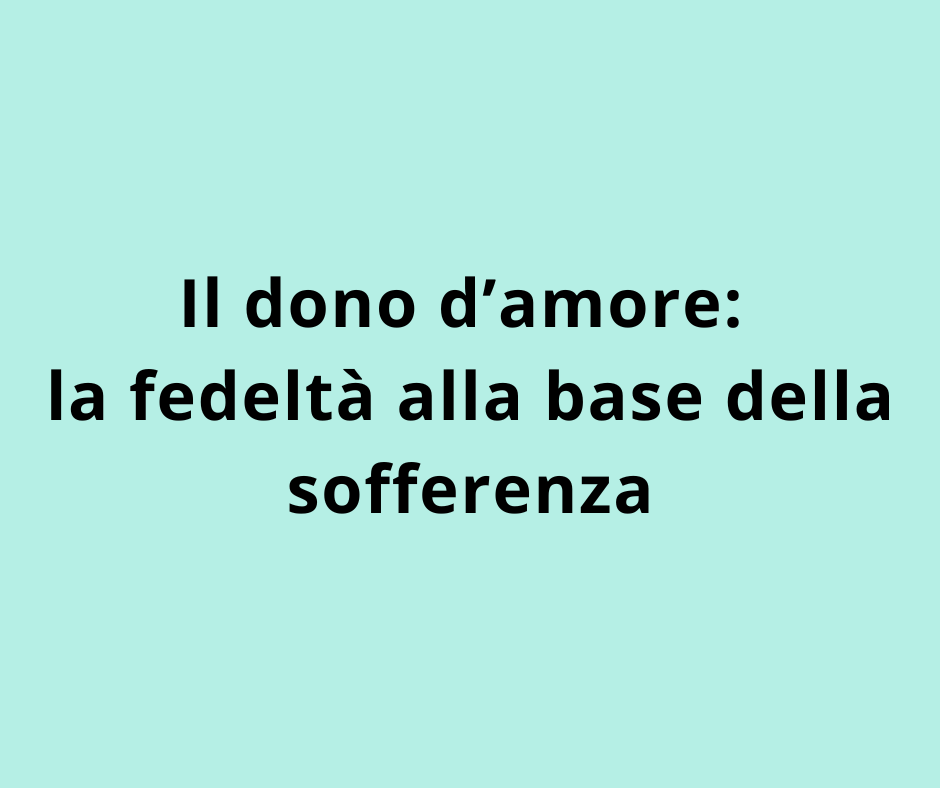
Dietro molti comportamenti patologici, dietro a sintomi che sembrano inspiegabili o resistenza al cambiamento che frustrano pazienti e terapeuti, si nasconde spesso una verità emotiva profonda: la sofferenza non è sempre un errore da correggere, ma può essere un atto di amore. È questo l'intuizione centrale della psicologa americana Lorna Smith Benjamin, che ha lavorato a una teoria originale toccante all'interno della sua Interpersonal Reconstructing Therapy (IRT). Secondo Benjamin, alla base di molte patologie c'è un gesto di fedeltà affettiva verso le figure di attaccamento primarie - un dono d'amore che il paziente offre inconsciamente anche quando quel legame è stato fonte di dolore.
In questa prospettiva il sintomo non è semplicemente un funzionamento da eliminare, ma una forma di lealtà emotiva: la patologia come dono di un amore nei confronti di una figura di attaccamento dalla quale si ricerca approvazione, vicinanza emotiva.
Il paziente mantiene il comportamento disfunzionale perché abbandonarlo significherebbe, a livello profondo ed inconscio, tradire la persona, spesso il genitore, che ama. Anche se quel modello relazionale è fonte di sofferenza, ripeterlo rappresenta un modo per rimanere vicino a quella figura di attaccamento. Una forma d’amore antico, silenzioso che si esprime attraverso il dolore.
Benjamin descrive tre processi fondamentali attraverso cui questo "dono d'amore" si manifesta ovvero: si tratta di tre processi di copia chiamati ricapitolazione, introiezione ed identificazione.
Ricapitolazione ("Agisci come se lui o lei fosse qui e avesse il controllo"): l'individuo si relaziona come se la figura genitoriale fosse ancora presente, come se continuasse ad esercitare l'influenza, proponendo situazioni in cui quella figura domina, controlla, critica. Quell'adulto si comporta come se fosse ancora bambino o bambina di fronte al genitore. Si verifica quando il paziente si comporta con gli altri esattamente come se si trovasse di fronte al genitore: compiacendo l'altro, avendone timore, mantenendo fedelmente le sue regole, i suoi valori e il suo modo di vedere il mondo.
Introiezione ("tratta te stesso come lui o lei ti trattava"): in questo caso, il soggetto interiorizza il comportamento la figura di riferimento e lo rivolge contro se stesso: auto-critiche, svalutazioni, punizioni interiorizzate. È il processo attraverso cui il paziente interiorizza il modo in cui è stato trattato: si giudica, si punisce, si svaluta, similmente a quanto gli stati impartito ritenendo di meritarsi ciò.
Identificazione ("devi essere come lui o lei"): il soggetto agisce come la figura di riferimento: si comporta, pensa e reagisce in modi simili a quel la persona. Il processo per cui il paziente assume tratti, comportamenti, atteggiamenti la figura genitoriale, integrandoli nel proprio senso di sé. Una forma di fusione profonda, i cui confini tra sé e l'altro si dissolvono. Il paziente non solo ripete, ma diventa quella figura, spesso per proteggere la memoria per sentirsi ancora legato.
Identificazione per opposto (o per contrario): il soggetto assume un comportamento opposto rispetto al modello genitoriale, come forma di differenziazione. Anche questo modo di mantenere un legame, pur prendendo le distanze.
Appropriazione creativa (detta anche riformulazione personale): il soggetto trasforma in modo attivo il soggettivo, il modello ricevuto; prende ispirazione, ma rielabora ciò che ha ricevuto in base alla propria individualità.
Guarire significa accettare di separarsi interiormente da chi abbiamo amato intensamente, o da chi abbiamo sperato ci vedesse e ci amasse, anche solo a certe condizioni, anche semmai davvero in modo autentico. Lasciare andare spesso più difficile che soffrire. Il sintomo diventa così una forma di continuità affettiva, una testimonianza silenziosa di un legame che non si vuole spezzare.
Molti pazienti arrivano in terapia con sintomi cronici - depressione, ansia, disturbi relazionali - che sembrano resistere a ogni tentativo di cambiamento. Alcuni si puniscono costantemente, altri si sabotano nei momenti di successo, altri ancora scelgono una relazione che produce dinamiche dolorose. Quando si esplora attentamente la loro vita passata, emerge spesso una figura genitoriale o affettiva che ha trasmesso un modello di relazione rigido, svalutante, emotivamente distanziante. Il paziente, pur soffrendo, continua a ripetere quel modello. Non perché non voglio stare meglio, ma perché quel comportamento è diventato una forma di amore: un modo per stare fedele a chi lo ha cresciuto, per non tradire quel legame, per sentirsi ancora vicino nella speranza di essere amato e accettato proprio copiando, ricalcando il modello di riferimento. "Se faccio come te, divento come te, allora siamo simili, allora finalmente mi amerai e accetterai". Perché quella vicinanza significa che "se mi tratto come mi trattavi tu, se mi comporto come ti comporteresti tu, se tratto gli altri come li tratteresti tu", allora ci somigliamo e io sogno degno del tuo amore.
Nel lavoro clinico, il terapeuta non si limita a combattere il sintomo, ma cerca di comprendere la funzione che quel sintomo ha nella vita della persona. Il primo passo aiuta il paziente a riconoscere che ciò che lo fa soffrire non è solo un disturbo, magari da contenere farmacologicamente, ma c'è sotto molto di più. Il sintomo è una forma di continuità affettiva, una testimonianza silenziosa di un legame che non si vuole spezzare nel visione che portando avanti uno o più di questi processi prima o poi verrà soddisfatto il bisogno di accettazione, appartenenza, amore da parte della figura primaria anche nella misura in cui quella figura non è più al mondo. Riconoscere che il sintomo parla di dinamiche profonde e già trasformativo: permette di vedere il sintomo non come un nemico ma come un messaggero di un processo di funzionamento relazionale. Successivamente, si esplora la modalità con cui questa fedeltà si manifesta. Il terapeuta guida il paziente nel riconoscere che sta ripetendo comportamenti appresi ovvero ricapitola, si tratta come stato trattato, ovvero introietta, o sta assumendo il ruolo del genitore, ovvero si identifica.
Questo lavoro non è solo cognitivo ma profondamente emotivo: si tratta di dare il nome a ciò che è stato vissuto, far emergere l'antico bisogni di accettazione amore da parte della figura genitoriale. E elaborare il dolore di questa mancata accettazione con la figura reale, comprendere il tentativo inconscio di ricercare accettazione in figure altre attraverso questi meccanismi una volta che il paziente ha compreso il legame che sostiene il sintomo, il terapeuta aiuta validare la persona. Non si chiede di rinnegare il passato, ma di colorarlo in modo diverso. Il paziente può riconoscere che quel gesto d'amore è stato necessario, ma che rappresenta ma che rappresenta una strategia Infantile. Il processo disfunzionale rappresenta una tentata soluzione infantile che però, trasportata nell'età adulta, e solo causa di sofferenza e limitazione il paziente ad adulto può scegliere di amare se stessi in modo nuovo, può cercare relazioni appaganti all'esterno attraverso dinamiche sane.questo passaggio delicato implica un distacco emotivo dal modello originario; questo rappresenta un lutto da elaborare. Il lutto include il vissuto di tradimento e dolore rispetto alle figure di attaccamento. Infine si lavora per costruire nuove modalità relazionali, nuove forme di auto-percezione; i pazienti impara a trattarsi con rispetto, riconosce i propri bisogni, costruire relazioni basate sulla reciprocità e non sulla ripetizione copionali di uno schema appreso nel passato. Il cambiamento non è immediato, ma progressivo: nasce dalla consapevolezza cresce nella libertà, si consolida nella scelta.
Come scrive Benjamin: "il cambiamento non avviene combattendo il sintomo, ma comprendendo il legame che lo sostiene". In definitiva il dono d'amore è una chiave preziosa per comprendere l'resistenza al cambiamento. Una testimonianza di quanto l'essere umano sia profondamente relazionale, di come anche il dolore possa essere un modo per restare vicini alle figure primarie.
Il lavoro terapeutico invita a trasformare la fedeltà in libertà, e l'amore in guarigione. Perché solo quando il paziente può scegliere chi essere, senza avere dover ripetere ciò che è stato, la sofferenza può finalmente lasciare spazio alla crescita.

Dr. Maurizio Sgambati
Psicologo a Pordenone



