Quando l’amore si traveste da terapia: il partner come terapeuta
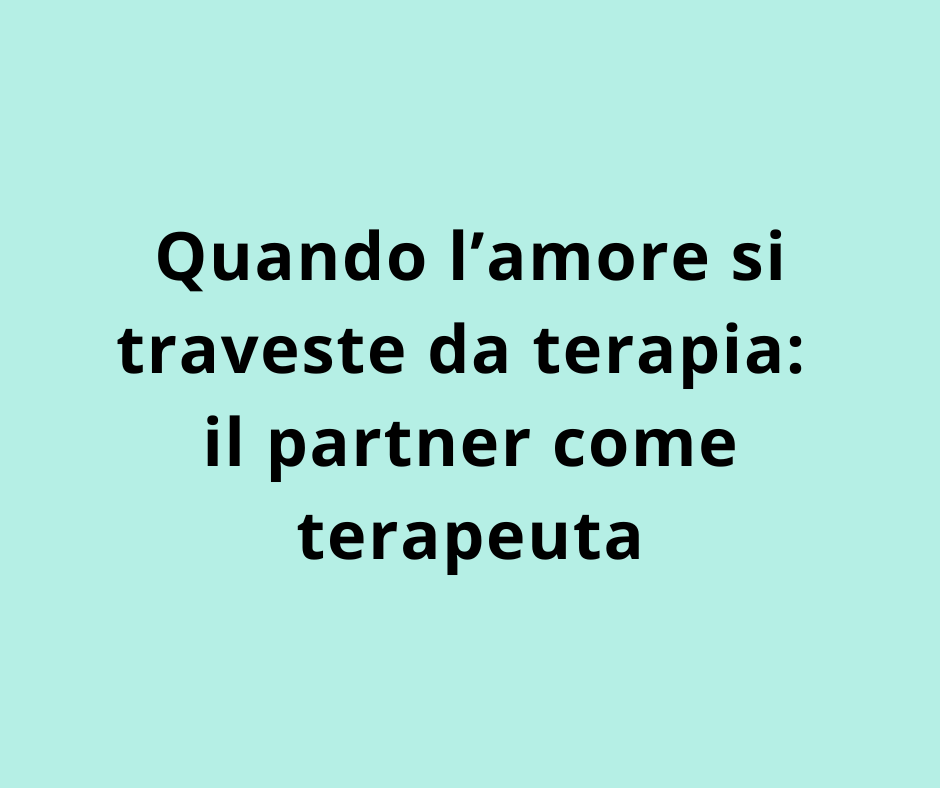
In molte relazioni affettive, il confine tra amore e cura può diventare sfumato. Ci si ama, ci si sostiene, ci si accompagna nei momenti difficili. Ma cosa accade quando uno dei due partner assume - spesso senza rendersene conto - il ruolo di terapeuta dell'altro? Quando l'intimità si trasforma in analisi, il sostegno in funzione, il legame affettivo in una seduta permanente?
Questo articolo esplora una dinamica relazionale tanto diffusa quanto poco conosciuta: quella in cui l'amore si traveste da terapia. Un fenomeno che può sembrare generoso, ma che nel tempo rischia di creare dipendenza, squilibrio e perdita di autenticità. Per amare non significa curare. E quando il bisogno prende il posto della scelta, la relazione smette di essere uno spazio di libertà.
Ci sono relazioni che nascono nell'amore e si sviluppano nella cura, ma finiscono per trasformarsi in qualcosa di diverso: una terapia mascherata da intimità. Senza che nessuno lo abbia deciso apertamente, uno dei due partner comincia a farsi carico del dolore dell'altro, lo ascolta come farebbe uno psicologo, lo incoraggia come un motivatore, lo consola come un genitore. Lo fa con dedizione, con affetto, con la convinzione che aiutare significhi amare. Ma in questa dinamica, qualcosa si incrina. L'amore smette di essere uno spazio condiviso e diventa una seduta terapeutica permanente. Questa trasformazione spesso sottile, invisibile agli occhi di chi la vive. Il partner-terapeuta non si accorge del riassunto di un ruolo che non gli spetta. Lo fa per proteggere, per sostenere, per "non lasciarlo solo". Ma il tempo, la relazione perde la sua parità. Non è 1 incontro tra due adulti, ma una relazione sbilanciata, dove uno guida, assumendo funzione genitoriale, e l'altro si appoggia, assumendo funzione infantile. Dove uno interpreta e l'altro viene interpretato. Dove uno si consuma e l'altro resta fragile.
Da un punto di vista psicologico, questa dinamica può essere letta come una confusione di ruoli affettivi. Chi si fa carico dell'altro spesso agisce da una posizione di superiorità emotiva: si sente più stabile, più consapevole, più capace. E l'altro, implicitamente, viene collocato nel ruolo di "bisognoso", "da correggere", "da saldare". Questo squilibrio genera una dipendenza relazionale che, invece di guarire, cristallizza la fragilità.
Il paradosso è evidente: più si cerca di aiutare, più si impedisce all'altro di crescere. L'amore che si fa terapia può diventare una forma di controllo sottile. L'altro resta legato non prescelta, ma per necessità. E chi cura, invece di sentirsi gratificato, si trova svuotato, invisibile, intrappolato in un ruolo che lo allontana da se stesso.
Questa dinamica può essere interpretata attraverso il concetto di tentata soluzione disfunzionale: cerca di risolvere un problema (la sofferenza dell'altro) con una strategia che nel tempo, lo alimenta. Più si cerca di "aggiustare" il partner, più si rafforza la sua dipendenza. È come costruire una casa per due, ma di darci da soli. È importante ricordare che l'amore non è una terapia. Può essere uno spazio sicuro, accogliente, empatico. Ma non può sostituire un percorso terapeutico professionale. Quando l'amore diventa funzione, perde la sua spontaneità. Si entra in una relazione dove il bisogno prevale sulla libertà, e il ruolo prende il posto della persona. Questa dinamica può anche ostacolare la crescita personale di entrambi. Il part-terapeuta rischia di costruire la propria identità relazionale attorno alla funzione di "guaritore", perdendo il contatto con i propri bisogni autentici. Il partner-paziente, invece, può sviluppare una dipendenza affettiva, delegando all'altro la responsabilità del proprio benessere.
Uscirne richiede consapevolezza. Significa restituire all'altro la responsabilità della propria evoluzione. Significa smettere di interpretare ogni gesto, ogni silenzio, ogni crisi. Significa tornare a essere partner, non terapeuti. E soprattutto, significa ricordare che l'amore non guarisce - ma può accompagnare. Non salva - ma può sostenere. Non risolve - ma può accogliere.
In fondo, amare davvero è lasciare che l'altro guarisca con le proprie forze, i propri tempi, sapendo che si può restare accanto senza doverlo salvare, accettandolo così com'è. E scegliere l'altro non perché ha bisogno di noi, ma perché ci riconosce. E riconoscerlo, non per ciò che manca, ma per ciò che è, nonostante i suoi limiti.
Se ti sei riconosciuto in queste dinamiche, non è motivo di colpa, ma di consapevolezza. Molti di noi, mossi dall'amore dal desiderio di proteggere, finiscono per assumere ruoli che non ci appartengono. Ma l'amore non è una terapia e il partner non è un paziente. L’amore sano è fatto di presenza, non di salvataggi; di ascolto, non di diagnosi; di libertà, non di dipendenza.
Riconoscere quando stai "curando" invece di amare è un atto di maturità emotiva. È il momento in cui smetti di portare l'altra sulle spalle e scegli di camminare accanto. Perché solo quando entrambi sono liberi di essere se stessi, la relazione può diventare davvero uno spazio di crescita, di incontro e di verità.
Se questo tema ti ha toccato, prenditi un momento per riflettere: stai amando o stai curando? E cosa succederebbe se lasciasse all'altro il diritto di guarire da solo?

Dr. Maurizio Sgambati
Psicologo a Pordenone



