L'appartenenza: il filo invisibile che ci tiene insieme
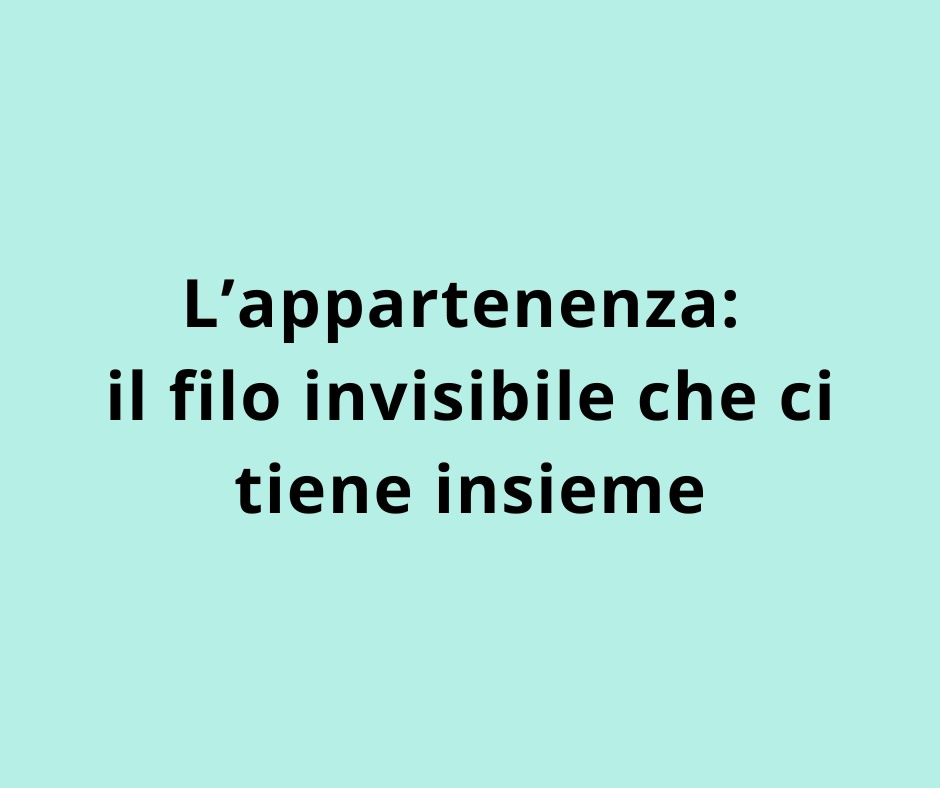
L'essere umano nasce dentro un legame. Prima ancora di avere un nome, apparteniamo. Siamo creature sociali, progettate per vivere dentro un "noi" che ci sostiene, ci orienta, ci protegge. Il bisogno di appartenenza non è un dettaglio emotivo: una struttura portante della nostra identità, un istinto antico che continua a pulsare sotto la pelle anche quando crediamo di essere adulti, autonomi, indipendenti.
La psicologia evoluzionistica ci ricorda che per millenni essere parte di un gruppo a significato sopravvivere. Il nostro cervello si è sviluppato in un mondo in cui restare soli equivaleva essere vulnerabili. Per questo la solitudine prolungata attiva le stesse aree cerebrali del dolore fisico, l'esclusione sociale viene percepita come una minaccia. Non è un capriccio: è biologia. È memoria evolutiva. L'antropologa Mary Douglas sosteneva che ogni gruppo umano definisce confini: chiede dietro, chi è fuori, chi appartiene e chi no. E quando siamo noi a essere spinti oltre quel confine, il corpo reagisce come se fosse in pericolo. L'esclusione non non è un fastidio: è un allarme.
La famiglia è il primo "noi" che abitiamo, la prima cultura che impariamo a parlare. Ogni famiglia ha un suo linguaggio emotivo, rituali, regole non dette, modi specifici di esprimere affetto o conflitto. Minuchin, padre della terapia familiare strutturale, parlava di "confini": permeabili, rigidi, caotici. E quei confini determinano se un figlio si sente accolto tollerato, riconosciuto condizionato. Ci sono famiglie che accolgono e famiglie che condizionano l'appartenenza al rispetto di aspettative rigide: "sei dei nostri solo se fai ciò che ci aspettiamo da te". Quando un figlio non rientra nei parametri - per scelte di vita, orientamento, sensibilità, desideri - può sperimentare una forma di esclusione che non lascia lividi sulla pelle, ma incide in profondità. È un dolore antico, primario: essere buttati fuori dal proprio stesso luogo d'origine. Nathanson, studiando la vergogna, descrive questo vissuto come una ferita identitaria: non è solo "non mi vogliono", ma "non sono degno di essere visto".
Secondo la Social Identity Theory, il gruppo di amici non è un contorno della nostra vita: una parte del nostro sé. Attraverso gli altri ci vediamo, ci definiamo, ci confermiamo. Winnicott direbbe che abbiamo bisogno di uno "sguardo che ci restituisce", di un ambiente che ci riflette in modo sufficientemente buono. Quando il gruppo ci riconosce, l'identità si rafforza. Quando ci rifiuta, si incrina. L'amore è la forma più intensa di appartenenza. Non ci basta essere tollerati: vogliamo essere visti. Vogliamo che qualcuno dica, esplicitamente o implicitamente: "tu hai posto qui". Bowlby, parlando di attaccamento, non descriveva solo un bisogno infantile, ma un bisogno umano: avere un luogo in cui tornare senza dover contrarre parti di sé.
Anche la coppia è un contesto di appartenenza, un "luogo emotivo" che ci identifica e in cui respirare amore e accettazione. Ma anche nella coppia ci può essere una forma di esclusione di cui si parla poco: quella che nasce quando una coppia si separa. Anche gli adulti, anche più razionali, possono sentire di essere stati espulsi dal nucleo che li definiva: e per i figli, la separazione può essere vissuta come una frattura del "noi" originario: non solo a ma mamma e papà non stanno più insieme, ma il bambino può percepire - anche senza parole - di essere diventato un ospite a metà, un appartenente, a tempo". Bronfrenbrenner direbbe che quando il microsistemi familiare si riorganizza, l'intero ecosistema interno del bambino deve ristrutturarsi.
Gli studi di Asch e Sherif mostrano quanto siamo disposti a rinunciare alla nostra autenticità pur di non essere esclusi. Paghiamo adattandoci, nascondendo parte di noi, rinunciando a desiderio orientamenti che non trovano spazio nel gruppo. Il costo psicologico è alto:
- vergogna;
- isolamento interno;
- iper-adattamento; frammentazione identitaria.
È un dolore silenzioso, ma persistente.
Con l'età adulta, abbiamo la possibilità di costruire appartenenze nuove. Le amicizie profonde possono diventare base sicure, luoghi in cui sperimentare parti di noi che erano rimaste in ombra. Sono gruppi che ci scelgono e che scegliamo, i propri per questo possono riparare ferite antiche. Quando costruiamo una nuova famiglia - tradizionale o non tradizionale generiamo un nuovo sistema di appartenenza. È un gesto identitario: integriamo passato e futuro, rinegoziamo ciò che abbiamo ereditato e lo trasformiamo in qualcosa di nostro.
La morte dei genitori, una frattura dell'appartenenza originaria. Molti adulti descrivono questo momento come un improvviso passaggio da "figlio dentro un sistema ""adulto senza un sopra". È un lutto identitario, oltre che affettivo. Si apre un nuovo spazio psichico, spesso difficile da abitare, ma anche fertile per ridefinire chi siamo e a chi apparteniamo ora.
Crescere significa imparare a riconoscere quali appartenenze ci nutrono e quali ci consumano. Accettare che alcuni "noi" si spezzano, che altri cambiano forma, che altri ancora dobbiamo crearli da zero. E capire che non siamo sbagliati quando non troviamo posti in un gruppo: a volte è il gruppo a non avere lo spazio per ciò che siamo diventati. La maturità non è rinunciare al bisogno di appartenere, ma scegliere luoghi in cui non dobbiamo rimpicciolirci per entrare. Luoghi in cui possiamo respirare, crescere, essere visti. Perché l'appartenenza non è un premio da meritare. È un diritto umano fondamentale: quello di essere riconosciuti.

Dr. Maurizio Sgambati
Psicologo a Pordenone



